Lo scontro politico – ma a tratti appare ideologico – sulla cosiddetta privatizzazione dell’acqua ci lascia un po’ perplessi. Non siamo filogovernativi. Non siamo mai “filo” per nessun motivo preconcetto. Crediamo che la caratteristica dell’Uomo essendo la ragione, questa debba essere utilizzata prima di esprimere un giudizio
Ecco perché, scusate la digressione, tanti si danno da fare per controllarla, umiliarla, deviarla: al diminuire dell’informazione cala proporzionalmente la capacità di ragionare e, spesso, lo spazio rimasto vuoto viene occupato dall’ideologia che, come diceva il grande saggista e linguista Roland Barthes, sostituisce l’intelligenza.
Torniamo alla privatizzazione dell’acqua.
Ragionamento complesso
Avvertiamo i lettori che il ragionamento è complesso, articolato, e dunque non riconducibile ad uno slogan. Anche perciò nessuno ragiona più: perché lo spazio a disposizione sui giornali, nei programmi televisivi (porteaporte o annizeri non c’è differenza) e nelle aree commenti dei blog non basta a contenere un ragionamento che vada oltre l’elementare formulazione di dieci pensierini.
La normativa comunitaria
Il punto di partenza del ragionamento non può che essere la normativa comunitaria e l’indicazione che contiene: le amministrazioni pubbliche – dicono i legislatori comunitari (che, è bene ricordarlo, non sono una categoria dello spirito ma gli stessi che rispettivamente legiferano nei loro singoli Paesi di provenienza e su questa oggettiva osservazione si innesta il vecchio problema tutto italiano dell’assoluta ignoranza di cosa è e come funziona l’Unione Europea) – devono essere lasciate libere di scegliere se affidare i servizi pubblici ai privati o gestirli direttamente.
E già quest’affermazione, in Italia, viene giudicata con schizofrenico sospetto.
Schizofrenia italiana
Perché schizofrenico? Perché siamo un Paese che oscilla tra il disprezzo del pubblico causato dalle sue secolari inefficienze (accompagnato dall’apologia del privato, tanto da affidare la guida del governo ad un imprenditore sostenendo – così si diceva all’inizio – che chi riesce a far funzionare la sua azienda finalmente riuscirà a far funzionare lo Stato), e il disprezzo – allo stesso tempo – del privato ritenendo, in particolare, di non poter fare affidamento sul privato scelto da “quel” pubblico, ossia da quella stessa amministrazione che disprezziamo.
Scarsa fiducia
Come potrà mai funzionare, senza coltivare interessi occulti, inconfessabili e contrari ai bisogni dei cittadini, un servizio affidato ad un privato scelto da quell’amministrazione che non funziona? Soprattutto – e questa equazione si è dimostrata spesso vera nella storia recente – il privato viene scelto non per le sue capacità ma solo in base agli interessi personali: nella migliore delle ipotesi in nome di quel costantemente presente conflitto d’interessi privato-pubblico (che tuttavia noi stessi abbiamo creato affidando il governo pubblico ad un governatore privato…), e nella peggiore in base alla capacità corruttiva da un lato e alla disponibilità ad essere corrotti dall’altro.
Così non ci fidiamo dei risultati di un concorso pubblico, di una gara d’appalto, di una qualunque gestione – appunto – privatizzata. In sostanza, non ci fidiamo della correttezza (tecnica) e della legalità (etica prima ancora che giuridica) delle decisioni del pubblico.
Le contraddizioni
E però, contemporaneamente – e per gli stessi motivi – consideriamo il pubblico incapace. Si tratta ovviamente di un’inconciliabile contraddizione: qualcuno, pubblico o privato che sia, dovrà pur gestire qualcosa per conto della collettività. L’unico modo, in una democrazia che funziona, per comporre tale contraddizione è nella scelta dei rappresentanti pubblici che decidono, all’occorrenza, quando, cosa e come affidare ai privati. Ma la gente d’Italia non è capace nemmeno di trarre le necessarie conseguenze dalle sue stesse convinzioni (giuste o sbagliate non importa: in questo caso, ma solo in questo, è vero che la volontà popolare è sovrana). Allorché infatti si tratta di scegliere i propri rappresentanti, quegli stessi cittadini che riempiono i blog, le email, le piazze di contestazione e disprezzo, vanno ordinatamente a depositare nell’urna il proprio voto per le stesse persone che il giorno prima erano oggetto di quel disprezzo. E non vale, come alibi, sostenere che “tanto sono sempre ‘loro’ che decidono”, che “tanto questo o quello noi lo prendiamo sempre nel…” e così via. Questa è filosofia da autobus (e gli autobus sono un servizio pubblico che non accontenta quasi nessuno ma quegli stessi scontenti lo sarebbero ancora di più se si proponesse di affidarlo ai privati). L’alibi non vale semplicemente perché è falso. Ad ogni consultazione elettorale le formazioni, i simboli, le alleanze, le liste civiche, gli improbabili partiti dell’ultim’ora sono più di quanti se ne possa contare. Eppure mai una volta che, ad esempio, la Lega per la salvaguardia dei cani marroni, abbia miracolosamente ottenuto il 30 per cento dei consensi, non fosse altro che per protesta. Al massimo, sale vertiginosamente la percentuale di astensioni, che equivalgono ad una cambiale in bianco firmata dalla massa a beneficio di un singolo: se la metà della popolazione non vota, di fatto si rimette alla scelta dell’altra metà e anzi, visti gli ovvi meccanismi di un’elezione, a quel 25 per cento più 1 che porterà al successo una delle parti in gioco. In teoria il governo di 100 milioni di cittadini potrebbe essere scelto, così facendo, da 25 milioni e 1 persona così che gli altri 75 milioni meno 1 potrebbero dichiararsi insoddisfatti. Peccato però che, in questo caso, perderebbero il diritto (sul piano etico-sociale) di protestare: potevano pensarci prima (a patto che non abbiano perso la capacità di pensare).
E allora: senza dimenticare queste premesse – che non sono opinioni ma constatazioni – riprendiamo l’affermazione dell’Unione Europea.
 Il ruolo della Ue
Il ruolo della Ue
Il compito principale della Ue, il motivo per cui è nata, è garantire la circolazione delle risorse – umane, finanziarie, industriali – nella convinzione che lo sviluppo può essere favorito soltanto da una crescente integrazione tra privato e pubblico, da un sempre maggiore impegno del privato, guidato e vigilato dal pubblico – questo inciso è importante: nei ragionamenti ci sono cose importanti da ricordare, a differenza dei pensierini – affinché l’utile del singolo coincida sempre più con l’interesse collettivo. Non a caso il Mercato Europeo Comune (ricordate? Il Mec) era tra le prime formazioni “operative” di quella che un tempo era la Comunità economica europea. E, sempre non a caso, la Comunità europea, prima di essere “Unione”, era “economica”. Come dire: l’unione (che, è proverbiale, fa la forza) si salda in nome dell’economia. Anche Marx, dal suo punto di vista, aveva già capito che l’economia è ciò che fa funzionare il mondo. In ambito politico e internazionale, soprattutto, l’economia sta al “primo motore immobile” dantesco o al sesso nelle teorie di Sigmund Freud. Dunque l’Unione europea funziona – e garantisce il funzionamento – in nome dell’economia e del bilanciamento degli interessi tra privati e tra pubblico e privato (alla faccia di chi continua a sfondare le vetrine di McDonald ritenendo che sia un simbolo dell’America, anzi Amerika, capitalista).
Il mercato
In quest’ottica la Ue non si spiega perché (la componente italiana è soltanto una piccola parte del consesso legislativo europeo dove, di conseguenza, negli interrogativi e nelle soluzioni prevale la coerenza, la legalità e il senso dello Stato) ci debba essere un Paese che non prevede la possibilità di “mettere sul mercato” (comune) i suoi servizi pubblici. In questo modo, pensa un legislatore abituato a vivere in un sistema amministrativo che funziona e non in una videocrazia monarchica piena di cittadini-sudditi, se l’ente pubblico ritiene di poter – o di dover – gestire direttamente il servizio, può farlo ma ciò non impedisce a un altro ente pubblico di affidarlo invece a un privato che, magari, ha competenze che l’ente (perché piccolo, perché povero) non ha e dunque può garantire un buon servizio a buone condizioni. Buone condizioni non significa gratis, ma con una politica tariffaria che tenga conto sia della “economicità” (nel senso della matrice economica) della gestione, sia del fatto che comunque quel servizio è di interesse pubblico. Insomma una gestione privata sotto la vigilanza e d’accordo con il pubblico e dunque un bilanciamento tra interessi e garanzie, diritti e opportunità.
In Italia però nessuno si fida. E già, pensano, figuriamoci cosa succede: l’acqua viene affidata a imprenditori senza scrupoli amici degli amici che la fanno pagare un occhio della testa e tutti i poveri restano, è il caso di dire, a bocca asciutta.
Più le critiche dilagano più scende il coefficiente dell’informazione che dovrebbe dare senso alla critica. Si scivola così, ancora una volta, verso quel pollaio starnazzante fatto di blog, email e rigurgitante di quella informazione “che viene dalla base” grazie alla cloaca telematica della “Rete” dove tutti dicono tutto e dunque nessuno capisce niente (da Facebook ai siti di presunta informazione che dopo aver dato una notizia tanto sintetica quanto mistificata invitano il lettore: “dì la tua”, come se fossimo in un bar dello sport dove il buon vecchio e inoffensivo scemo del villaggio è stato sostituito da un esercito di moderni e devastanti scemi del villaggio globale).
La bugia italiana
Su un punto alcuni dei galli di questo pollaio hanno ragione. E non è un punto secondario, quanto a valenza profetica: mentre l’Unione Europea ha raccomandato agli Stati di favorire la libera scelta delle amministrazioni su chi dovesse gestire i servizi, il disegno di legge che il 19 novembre scorso ha convertito il decreto legge approvato a settembre, prevede senza mezzi termini che la gestione dei servizi pubblici locali deve essere conferita agli imprenditori. Detta così, puzza lontano un miglio di affare da spartirsi.
Cosa dice la legge
Però: dice proprio così la legge? E poi: cosa cambia realmente rispetto alla situazione attuale? Inoltre: cosa c’è di nuovo rispetto ad altri servizi ugualmente primari e di interesse pubblico?
Vediamo.
Il secondo e il terzo comma dell’articolo 15 del decreto legge approvato a settembre scorso, convertito dal disegno di legge Ronchi, nel richiamare sostanzialmente il secondo comma dell’articolo 23bis del decreto legge 25 giugno 2008 numero 112, così dicono: “ Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.
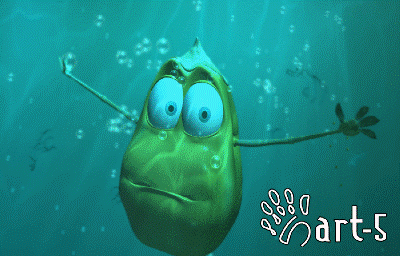 Le tre domande utili
Le tre domande utili
Ora possiamo provare a rispondere alle tre domande che ci siamo posti. Prima domanda: è vero, nella legge è scritto che “la gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite…” (e tralasciamo il rilievo linguistico secondo il quale la gestione non “avviene” ma “viene affidata”). Quell’in via ordinaria vuol dire che normalmente deve essere così: la regola generale è questa. Però, sempre per restare alla prima domanda, la legge non dice solo questo. Dice anche che, sempre in via ordinaria, cioè sempre per regola generale, la gestione di quegli stessi servizi viene affidata a “società a partecipazione mista pubblica e privata”. Potrà in sostanza verificarsi indifferentemente sia l’una che l’altra ipotesi.
Vengono poi fissati dei “paletti”, delle condizioni, da rispettare nella scelta di questi soci privati (bisognerà cioè ricorrere ad una sorta di gara d’appalto per scegliere il migliore).
Ancora: si precisa che questi soci privati non potranno avere una partecipazione inferiore al 40 per cento. Mentre non viene stabilito un tetto massimo di azioni della società di gestione che potranno andare ad un privato.
Per capirsi: potrà esserci una società al 90 per cento privata e al 10 per cento pubblica, ma non il contrario. L’ipotesi più… pubblicistica possibile è 60 per cento al pubblico e 40 al privato.
Ma ancora non è finita: sempre lo stesso articolo, al comma successivo ci spiega che “per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico”. E anche in questo caso vengono poste delle condizioni formali che possiamo lasciar perdere.
Le società miste e il pubblico da solo
Ricapitolando: se è vero che la regola generale prevede indifferentemente sia l’affidamento della gestione ai privati sia a società miste pubblico-privato, è anche vero che se si tratta di territori disagiati o – anche, e questo è importantissimo – caratterizzati da particolari condizioni economiche e sociali (quindi: zone depresse, comunità in via di sviluppo che hanno bisogno della “mano pubblica” che garantisca trattamenti di favore che non possono essere imposti all’economia d’impresa privata altrimenti l’Europa si arrabbia), i privati restano a casa e ci pensa l’ente pubblico a distribuire l’acqua.
La risposta alla prima domanda impone una prima conclusione: le comunità in difficoltà, che temono di essere penalizzate dai privati, possono fare affidamento sui loro rappresentanti pubblici e pretendere che l’acqua resti un servizio controllato interamente dal pubblico. In questo caso l’interesse (collettivo) ad una gestione pubblica pur con tutti i suoi eventuali limiti è superiore all’interesse (sempre collettivo) all’efficienza privata.
Se nonostante questa evidente conclusione si continua a protestare, allora il punto, come si vede, non è più: non ci fidiamo dei privati. Bensì: non ci fidiamo del pubblico. Insomma, chi protesta in questi giorni lo fa per la ragione sbagliata.
Così torniamo alla questione del pubblico che non funziona ma che continua ad essere nutrito dal consenso di chi, pur non fidandosi, continua ad appoggiarlo (in cambio di posti di lavoro, raccomandazioni, vantaggi più o meno illeciti, tutela per gli orticelli personali).
Cosa cambia?
Seconda domanda: cosa cambia rispetto alla situazione attuale? Per rispondere non serve imparare a leggere (le leggi o anche soltanto il Corriere dei Piccoli), ma è sufficiente guardarsi attorno, magari rinunciando all’ultima puntata di X Factor o della Ruota della fortuna.
Basta un esempio a chiarire le idee (dove ci sono): a Roma, la capitale d’Italia come ci insegnano a scuola – per chi c’è andato – la gestione del servizio idrico, l’acqua del rubinetto, è affidata ad una società mista pubblico privato: l’Acea. Il pubblico, cioè il comune di Roma, possiede il 51 per cento di questa società: la nuova legge gli consentirebbe di aumentare addirittura la partecipazione fino al 60 per cento. La nuova e vituperata legge cioè è più favorevole al pubblico di quanto lo sia la realtà attuale a Roma.
Per il resto, il pacchetto azionario dell’Acea, che è quotata in Borsa, è nelle mani della società francese – tutta privata – Gdf Suez (9,9 per cento), della famiglia Caltagirone (7,5 per cento) che come tutti sanno è molto privata anche se spesso molto vicina al pubblico, di una delle maggiori banche svizzere, la Pictet Funds del gruppo Banque Pictet (3,8 per cento) che più privata di così… e per il restante 27,8 per cento è collocata sul mercato borsistico. Anche chi sta leggendo queste righe potrebbe possedere qualche… litro dell’acqua che bevono i romani.
La situazione di Roma è comune a molte altre grandi città. E dove invece la società che gestisce l’acquedotto è a intera partecipazione pubblica, ad esempio a Napoli con l’Arin, si tratta pur sempre di una società per azioni. Cioè di un organismo di diritto privato che, sebbene di proprietà pubblica, può prendere le sue decisioni (e ad esempio aumentare le tariffe) in piena autonomia. Così come in piena autonomia decide quanto, dove e perché investire. Cosa che pare spaventi molto coloro che parlano della nuova legge senza conoscere il mondo che li circonda.
 L’acqua è già privata
L’acqua è già privata
In alcuni casi infatti il costo dell’acqua, nonostante la società di gestione abbia un azionariato tutto pubblico, è elevatissimo. L’Acquedotto Lucano, una Spa di proprietà regionale, per dirne uno, ha fissato tariffe solo in apparenza ridotte. Portando al limite minimo i consumi standard, tutto quello che esce in più dai rubinetti viene classificato come eccedenza, con relativa impennata dei costi. A ciò bisogna aggiungere i costi, fissati regione per regione, del servizio fognario (anche l’acqua potabile finisce nelle fogne e dunque con la fattura dell’acqua paghiamo la componente fognaria), e tutti gli altri che concorrono al prezzo finale. Morale della favola: in Lucania un metro cubo d’acqua può arrivare a costare, di fatto, tutto compreso, anche 3 euro e 50 centesimi. Anche se, in teoria, il costo “secco”, ossia senza le altre voci aggiunte, è di poco inferiore ad un euro. Stessa fine per l’acqua di Napoli (la tanto decantata acqua che sarà per merito suo se il caffè è così buono o anche la pizza, a sentire i luoghi comuni): il prezzo base è di quasi 1 euro e 50 a metro cubo. Risultato: aggiungendo le altre voci si arriva anche a 4 euro. Sia a Napoli sia in Lucania, lo ricordiamo, le società di gestione sono interamente pubbliche. Ma sono società per azioni. Si comportano cioè come se fossero dei privati. E ciò è previsto già dalle attuali norme.
In pratica, il problema è un altro e viene cancellato dalle polemiche starnazzanti.
Terza domanda: cosa ci sarà di nuovo, e di diverso, rispetto ad altri servizi di interesse pubblico? Anche in questo caso basta saper leggere e non serve nemmeno il Corriere dei Piccoli. Prendiamo l’ultima bolletta della luce, del gas, del telefono: risulta che le società di gestione siano pubbliche? Sfidiamo chiunque a sostenere che si tratta, in realtà, di beni non primari come l’acqua. Certo, in teoria sì, ma provate a fare a meno della luce, del gas e perfino del telefono. La definizione di bene primario rientra in una categoria relativistica: dipende dal contesto nel quale si vive. Diogene, tanti anni fa, dimostrò (anzi, lo imparò da un bambino) che anche una tazza di legno da riempire con l’acqua da bere può essere superflua. In teoria anche l’acqua, intesa come rubinetto che si apre e fa scorrere acqua potabile, non è un bene primario. Basta andare indietro di cento anni per scoprire che le fontane in piazza servivano anche per fare il bucato, oltre che per prendere l’acqua da portare a casa. E soltanto le famiglie più ricche potevano permettersi di avere un pozzo in cucina o nel cortile da dove costruire il loro acquedotto personale (privato).
Dunque, di nuovo, il problema è un altro.
Le argomentazioni degli esperti
Sulla questione idrice, in questi mesi, sono intervenuti in tanti. Alcuni esperti e molti demagoghi. Prendiamo le considerazioni di un esperto: Mario Tozzi, il bravo e simpatico geologo televisivo. Le considerazioni di Tozzi sono tutte condivisibili. In astratto. In concreto, la componente di parlatore professionale gli ha fatto dimenticare uno dei capisaldi della scienza (egli è anzitutto scienziato): l’osservazione empirica.
Garantire una dose di acqua gratis a tutti
Tozzi sottolinea, sostanzialmente, due punti. Il primo, come sempre, è rappresentato dagli effetti diabolici di una perniciosa privatizzazione della distribuzione idrica. Il secondo (Tozzi è uomo intelligente) prende atto della circostanza che portare l’acqua nelle case, e prima ancora renderla potabile, ha un costo e dunque è giusto pagare qualcosa, sebbene l’acqua sia un bene inestimabile e di tale superiore interesse che in teoria dovrebbe essere garantita gratis. Infine pone un corollario: gratis del tutto non è possibile ma in nome dell’interesse pubblico bisognerebbe garantirne una certa quantità gratis a ciascuno ogni giorno. E questa quantità la suggerisce: 50 litri al giorno.
Andiamo con ordine e partiamo dal primo punto: i privati (lo abbiamo visto, dice, in altri casi, anche all’estero) significano qualità di servizi immutata ma tariffe alle stelle. Una drammatica ma ovvia conseguenza, si dice, per assicurare il guadagno, unica ragione di vita dell’impresa privata, speculando sul fatto che il valore del bene “acqua” non ha prezzo e dunque, paradossalmente, non c’è limite all’aumento possibile dei costi atteso che nessuno può, comunque, farne a meno. In pratica, è l’estremizzazione (Tozzi questo non lo dice perché è geologo e non economista) di una regola individuata da Keynes: la legge dell’utilità marginale.
Il punto di arrivo di questo paradosso è, lascia intendere Tozzi, la morte per sete. Dunque la conclusione, inespressa ma evocata: affidiamo l’acqua ai privati e moriremo tutti di sete. La minaccia è suggestiva però, anzitutto, poco realistica.
Robin Hood e lo sceriffo di Nottingham
Se è vero che i privati vogliono fare i soldi (per dirla banalmente) e comportarsi come lo sceriffo di Nottingham nella favola di Robin Hood, che spremeva i poveri contadini fino all’osso per riscuotere sempre più tasse e ingrassare il perfido Principe Giovanni, nella realtà non funziona. Ammesso che tutti paghino l’acqua puntualmente nonostante le mostruose tariffe, ad un certo punto – in pochi decenni, che sono appunto pochi rispetto alle prospettive almeno trentennali di guadagno dei futuribili privati – nessuno avrebbe più nulla da pagare. Le popolazioni di città, comuni e metropoli si trascinerebbero assetate da una strada all’altra, i giardini, anche quelli comunali, rinsecchirebbero, migliaia di attività anche industriali che non possono fare a meno dell’acqua fallirebbero e l’effetto finale sarebbe assai simile a quello di una guerra termonucleare globale (per citare un famoso e divertente film che vi sfido a ricordare). E i privati, signori dell’acqua, sarebbero “padroni” (fino a un certo punto, perché la legge dice che la proprietà resta pubblica) di miliardi di litri di un liquido che nessuno è più in grado di acquistare perché sono stati tutti affamati (anzi, assetati) da una dissennata politica delle tariffe.
Sempre gli economisti, invece, ci insegnano che il valore di un bene, anche di un semplice tappo di sughero, non è tanto intrinseco quanto nella sua commerciabilità.
Se una persona possedesse tutto l’oro del mondo e pretendesse quattro volte tutto l’oro del mondo per venderne anche un solo grammo, di fatto morirebbe di fame. Sebbene circondato dall’oro. Perché nessuno sarebbe in grado di pagare il prezzo richiesto. Si troverebbe nella stessa situazione, quanto a capacità di produrre ricchezza, del più povero dei poveri.
I controlli
Gli storici, i sociologi, i politologi, e anche gli economisti (non riusciamo a liberarci degli economisti) ci insegnano inoltre che la differenza tra il villaggio di Nottingham e il mondo reale risiede nella capacità di quest’ultimo di creare dei meccanismi di autocontrollo. Non è questo il momento di ricordare il difficile e mai risolto del tutto dibattito (in dottrina e filosofia economica) sulla capacità del libero mercato di autogovernarsi. Pur dimostrando la storia, per chi la leggesse, i limiti incontrati da coloro che hanno provato a sostituirlo (il libero mercato, sostenuto ad esempio dalla scuola fisiocratica di Adam Smith), con altre forme di governo dell’economia fino ad arrivare al protezionismo e al monetarismo, è senz’altro vero che il totale liberismo presenta svantaggi (molti) e rischi (ancora di più). Negli ultimi cinquant’anni (dunque un periodo che anche Tozzi conosce bene) si è giunti alla conclusione – perfettibile, come sempre, ma per ora pare abbastanza accreditata – che è preferibile un liberismo etero guidato, o controllato, da strutture di controllo nazionali e sovranazionali che provvedano a mitigarne le esasperazioni.
Abbiamo già ricordato (ma perché nessuno ne parla, nemmeno nei commenti ai tanti blog?) le commissioni di garanzia che intervengono sulle tariffe elettriche, su quelle del gas e perfino sui costi telefonici, delle autostrade, delle ferrovie e dei giornali quotidiani. Tutti servizi, in sostanza, pubblici – nel senso quanto meno di pubblico interesse – che sono però, da decenni, gestiti da privati o perché privatizzati (come l’energia elettrica o il gas) o perché nati ad opera dei privati (come i telefoni).
I buoni e i cattivi
Ad una ipotetica banda di masnadieri privati che messe le mani sull’acqua cominciasse a comportarsi come Lex Luthor, il cattivo di nemico di Superman, o come Joker il nemico di Batman che vuole impadronirsi di Gotham City, perfino le nostre Authority, le authority all’italiana, riuscirebbero a rispondere. Forse un po’ lentamente, in modo non sempre incisivo (come fanno con le assicurazioni, i cartelli dei produttori di pasta e così via) ma pur sempre risponderebbero obbligandoli a non esagerare. Anche perché, in questo caso, si spera che il tanto ciarliero popolo della Rete una volta tanto alzi il culo dalla sedia davanti al video per fare qualcosa di più concreto. E non cominciamo a dire che tanto il popolo nessuno lo ascolta: se così fosse perché stiamo tutti parlando? Con quale prospettiva? Per dare aria alla bocca? Evidentemente perché riteniamo che possa servire. Bene: può servire. A patto però che si dicano cose sensate e fattibili, qualcosa che non fa parte delle favole di Robin Hood o di Superman ma che, per fortuna, può far parte della realtà. E che non sia un ridicolo girotondo o affollarsi in uno stadio per applaudire un comico che trova remunerativo fingere di essere un tribuno della plebe.
Insomma: a proposito della legge italiana cosa ci sarebbe di male a introdurre, con i decreti attuativi, una regolamentazione della tariffe in modo che gli aumenti non siano esposti agli umori (banditeschi) di questo o quel privato?
E’ molto più produttivo lottare affinché si raggiunga questo obiettivo. E in questo senso va proprio il secondo quesito referendario, quello cioè che propone l’abrogazione della parte della norma che permette ai gestori (a questo punto non ha importanza se privati o pubblici) di assicurarsi un reddito dal capitale investito attraverso un ricarico, un aumento, del prezzo dell’acqua.
Sempre per restare al problema italiano, senza (di)vagare in mezzo mondo assetato, se il catastrofico scenario immaginato da Mario Tozzi dovesse verificarsi, e le tariffe balzare alle stelle senza che nessuna commissione di controllo o garanzia possa o debba intervenire, in Italia chi non paga l’acqua – per giurisprudenza anche della Corte costituzionale – non può vedersene privato del tutto. Anche per l’energia elettrica è così. Per non parlare delle fabbriche, degli uffici, anche pubblici: se le tariffe vanno alle stelle mica ci andranno solo per i privati, per la casetta della povera vecchina che deve farsi il brodo di pollo? Vi immaginate le palestre e le piscine comunali, le scuole, le caserme, i ministeri, i tribunali, le forze dell’ordine che pagano milioni di euro per far piacere a Lex Luthor signore e padrone dell’acqua? E vi immaginate la acciaierie, le fonderie, l’industria siderurgica con i suoi sindacati e la sua Confindustria, i palazzinari, i grandi magazzini, le catene degli alberghi, i ristoranti? Per non parlare degli interessi dei grandi gruppi stranieri in Italia. Provateci voi a dire agli Hilton, quelli degli alberghi e della bella Paris, che i costi dell’acqua sono improvvisamente triplicati. Quelli non si limitano a chiedere il favore al furbetto del quartierino: scatenano una guerra commerciale globale, altro che termonucleare. E allora sì che interviene l’Europa e gli altri organi sovranazionali. Eccolo il meccanismo autoregolatore, anche se a beneficio immediato dei più ricchi, del liberismo. Eccola la differenza tra la foresta di Sherwood delle favole e la realtà. Se i privati facessero carne da macello con l’acqua in un Paese dall’economia e dalla società complessa e intrecciata con altri Paesi altre economie e altre società, il “narratore” non sarebbe libero di gestire la favola come vuole lui. E il tanto agognato guadagno dei privati andrebbe e farsi benedire.
Ai privati solo il 40 per cento
Non dimentichiamo che la legge prevede che le società di gestione, private, possano avere fino al 60 per cento di capitale pubblico. In qualunque società, anche in Italia, chi possiede il 60 per cento ha diritto a intervenire nelle decisioni. E allora, ancora una volta, invece di starnazzare genericamente contro la legge facciamo valere il nostro potere di cittadini affinché il pubblico eserciti questo diritto a conservare il 60 per cento delle azioni delle società di gestione dell’acqua.
Ricordiamo che a Roma, ad esempio, già da anni l’acqua è gestita da una società privata dove soltanto il 51 per cento – dunque meno del 60 previsto dalla norme comunitaria – è nelle mani del comune. Il resto è di palazzinari e banchieri. Non mi sembra che le strade di Roma siano affollate di assetati.
I costi attuali dell’acqua
E veniamo al secondo punto di Tozzi: è giusto pagare l’acqua ma più giusto ancora sarebbe che il pubblico la desse via gratis (l’acqua) e dunque almeno che assicuri una dose giornaliera, 50 litri, gratis.
Anche qui Tozzi (anche gli altri ma per uno scienziato è più grave) mostra di non aver speso nemmeno un minuto nell’osservazione.
Osserviamo la fattura di un qualunque acquedotto (anche tra i tanti privati che già ci sono). Per comodità (mia: concedetemelo) ho preso la bolletta dell’Acquedotto Lucano (ho una casa a Maratea). Nella specifica dei costi è, appunto, specificato che i prezzi sono legati a quattro blocchi di consumo diversi: tariffa agevolata, tariffa base, tariffa prima eccedenza, tariffa seconda eccedenza. Ogni blocco comprende una quantità predeterminata di metri cubi, ad eccezione dell’ultimo, il più caro, che può andare all’infinito.
In pratica la “politica dell’acqua” prevede che tutti abbiano diritto ad una prima “dose” a tariffa agevolata (un po’ come il 6 politico del Sessantotto): per i primi 33 metri cubi consumati ogni metro cubo – cioè mille litri – costa 52 centesimi di euro. Il prezzo per metro cubo della tariffa base sale a 0,66 centesimi e in questo scaglione rientrano altri 16 metri cubi, la prima eccedenza costa 1 euro e 5 centesimi ogni mille litri e questa fascia si esaurisce con altri 33 metri cubi, per arrivare alla quarta fascia con 1,62 euro a metro cubo. A questi costi vanno poi aggiunte quote fisse regionali, quote fognature, quote depurazioni, Iva, tasse locali eccetera tanto che, sempre per l’Acquedotto Lucano, si arriva quasi a 2 euro a metro cubo di media (223 metri cubi in 4 mesi tra agevolata, base, prima e seconda eccedenza e tasse costano 445,17 euro, dunque oltre 100 euro al mese di acqua, alla faccia dei privati).
Ma torniamo all’idea, ottima e condivisibile, di 50 litri d’acqua gratis al giorno per ciascuno. Con la tariffa agevolata dell’Acquedotto Lucano mille litri costano 52 centesimi. Dunque un litro costa 0,00052 euro. Detto in lire, che è più facile, un litro d’acqua costa 1 lira. Per 50 litri al giorno, cioè 1500 litri al mese, un cittadino lucano paga 1500 lire, ossia 77 centesimi di euro. Insomma: la proposta di Mario Tozzi è già, virtualmente, una realtà: con 77 centesimi al mese – 2 centesimi e mezzo al giorno – un italiano si assicura ogni giorno 50 litri di acqua potabile direttamente nel suo rubinetto. Anzi, se è ricco e può permettersi di spendere per l’acqua 52 centesimi al giorno invece di 77 al mese, in cambio è libero di consumare mille litri ogni 24 ore. Siccome però dormirà almeno 7 ore su 24, nel tempo che è sveglio può consumare 58 litri d’acqua ogni ora. Sempre per gli stessi 52 centesimi al mese.
Purtroppo però poi ci sono le tasse, le “accise”, l’Iva, le quote regionali, quelle federaliste, l’acqua del Po e le camice verdi, le siccità, le frane, i tubi che scoppiano, la pressione bassa, l’acqua inquinata. E poi i milioni di bambini dell’Africa che muoiono per mancanza d’acqua. E ancora il rischio che le amministrazioni locali italiane, e la politica italiana, non esercitino i dovuti controlli sugli impianti di distribuzione idrica, pubblici o privati che siano. Ma questi problemi non mi sembra siano collegati, né direttamente né indirettamente, al decreto Ronchi e all’acqua privatizzata in Italia. Sono tuttavia problemi molto gravi. Perché non proviamo a parlarne?
Il giusto rimedio
Non è però contestando la privatizzazione dell’acqua, in quanto tale, che si viene fuori da questo dilemma. Come diceva Cesare Pavese: i problemi sono iniziali. Le polemiche starnazzanti non sono l’inizio del problema, sono la conseguenza. Per zittire le galline bisogna cacciare la volpe dal pollaio, non discutere di come obbligarle al silenzio.
Sarebbe meglio concentrare le energie, anche quelle dell’opposizione politica, in un serio controllo parlamentare (anche se i termini “serio” e “parlamentare” appaiono anch’essi inconciliabili).
Basterebbe introdurre l’obbligo per il pubblico di controllare la politica tariffaria e l’efficacia e l’efficienza del servizio privatizzato. Nei Paesi anglosassoni esiste il difensore civico. Esiste anche in Italia. Lì funziona ed è temuto dalle istituzioni. Qui viene nominato dalle istituzioni tra i raccomandati servendosi del manuale Cencelli.
Le responsabilità del legislatore
La legge, anche questa legge contestata, continua a prevedere che l’acqua resti un bene pubblico. Dunque ciò che diventa privato è la sua gestione. Sul piano giuridico, il proprietario di un bene affidato in gestione a qualcuno ha tutto il diritto di stabilire dei tetti massimi ai prezzi di vendita. Non sarebbe una novità nemmeno per l’Italia: i prezzi dei quotidiani (indubbiamente privati) sono stabiliti dal pubblico, le tariffe telefoniche, del gas, dell’elettricità, perfino delle autostrade e dei treni (tutti beni o servizi privati spesso non solo nella gestione ma anche nella proprietà, a differenza dell’acqua che resta di proprietà pubblica) sono controllati e monitorati da autorità garanti e commissioni. Per non parlare della benzina o dei carburanti: più privato dei petrolieri…
Senza dimenticare che il cosiddetto decreto Ronchi, emesso in nome della legge Comunitaria del 2008, potrà essere corretto, dove è necessario, anche nei prossimi due anni. Lo prevede proprio la legge Comunitaria del 2008 che all’articolo 1, comma 5, dice: “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 (quelli cioè che danno attuazione ai principi indicati dall’Unione, tra i quali l’affidamento dei servizi ai privati), il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive”.
Il referendum
Ora i lettori ci accuseranno: e del referendum? In questo articolo non se ne parla? Come mi auguro abbiate capito non è così: se ne parla nel senso giusto. Riflettendo sulle vere domande che bisognerebbe porre e sulle vere risposte che bisognerebbe pretendere. Il referendum, invece, che nel contenuto è fondato sulle emozioni e non sulla razionalità (e il quesito in sé è anche falso perché non è vero che oggi l’acqua sia un bene gestito dal pubblico), può essere importante per i risvolti politici: votare “sì” significa esprimere dissenso verso l’attuale governo. Ma allora perché non raccogliamo le firme per un referendum che abroghi la norma che ha depenalizzato il falso in bilancio o quella che ha abbreviato i tempi di prescrizione? Anche in questo caso il voto sarebbe un modo per far entrare dalla finestra del referendum il dissenso politico che non riesce a entrare dalla porta delle elezioni, visto che – al momento giusto – la maggioranza vota per le persone sbagliate.
Lezione di vita?
Invece di starnazzare, controlliamo il legislatore, come prevedono le regole della democrazia.
Alla fine ci accorgiamo che volendo articolare qualcosa di più (di più utile) di una paginetta di frasette sull’acqua, scopriamo che parlare di privatizzazione dell’acqua ci fa scontrare con temi assai più ampi che riguardano la vita pubblica, la società, i diritti e i doveri, la democrazia. Non siamo però i primi ad accorgercene: se ne sono accorti, prima di noi, due persone di cui spesso leggiamo nei libri (se non ci limitiamo a guardare le figure) che si chiamavano Socrate e Aristotele. Accade sempre così quando si prova ad avere uno sguardo d’insieme.
Accade sempre così quando non si vuole fare la fine di quello scemo che, di fronte al dito che gli indicava la luna, guardava il dito.

